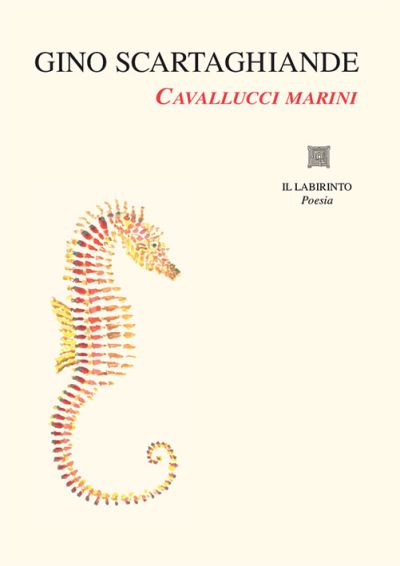
Con i Sonetti d’amore per King Kong, nel 1977 la poesia di Gino Scartaghiande arrivò potente se tra le voci che la salutarono poté esserci Amelia Rosselli, che vide bene quella dirompenza poetica «sorpassare l’individuale». Di «terribile forza di ironia, di dissacrazione, e nello stesso tempo di freschezza», parlò Andrea Zanzotto. Venne solo un altro libro, Bambù, nel 1988. Poi negli anni pubblicazioni clandestine, quasi postume – a rodere il coraggio del silenzio –, imposte da nascoste “caverne” dell’anima. Rare poesie, come incise, subito riconoscibili per rigore e accento, misura. Per le «sprezzature, le collisioni, gli scarti linguistici» come ebbe infatti a scrivere Domenico Vuoto.
Al poeta non era dato di morire. Lo aveva anche scritto: «Morire è un lusso che non possiamo permettere / né alla fantasia né alla pratica quotidiana». E così un primo resoconto, Oggetto e circostanza, nel 2016 c’è stato: riproposti gli introvabili due oggetti accompagnati dagli inediti sparsi e dimenticati. Ora l’autore con Cavallucci marini (innovativa nuova raccolta e “sintesi” del cammino precedente, dove “io” è sempre un altro) ci porge tutto il suo lavoro, unito in un disegno unico, in una scienza “contemplativa” di minute verità cocenti quanto accecanti.
